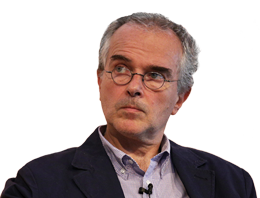Nel 1949, l’antropologo francese Claude Lévi-Strauss introduce il concetto di efficacia simbolica per analizzare il canto sciamanico dei Kuna di Panama per la cura dei parti difficili. Il canto agisce come un dispositivo metaforico che consente alla paziente di dare ordine a una esperienza di caos fisico e psichico e in questo risiede il suo potere terapeutico. Non necessariamente però questo effetto di cura è ancorato al significato delle parole del canto.
Le ricerche successive, infatti, hanno mostrato che la lingua dello sciamano è incomprensibile alle partorienti. Secondo Carlo Severi, il canto rituale contribuisce a creare un campo proiettivo condiviso che produce una “illusione percettiva guidata” e fa emergere ciò che non riuscirebbe a essere formulato in altro modo. Il canto abilita l’immaginazione della paziente, facilitando il percorso di risposta positiva alla situazione. “Un canto che racconta una storia stereotipata – la stessa per tutti – diviene un’immagine sorprendentemente fedele dell’esperienza e della storia segreta del paziente. E ciò semplicemente perché è il paziente stesso a costruire per sé la propria efficacia simbolica”.
L’analisi antropologica sull’efficacia simbolica trova corrispondenze significative negli studi sugli effetti nocebo e placebo. Per Howard Brody (2000) il corpo umano è cablato per tradurre l’immaginazione in forze naturali che guariscono. Il neurofisiologo Fabrizio Benedetti (2018), tra i massimi esperti degli effetti placebo e nocebo, racconta la cura come un rituale in cui si somministrano non solo farmaci ma anche spazi, odori, colori, parole, cioè stimoli sociali e simbolici. Il placebo non è semplicemente un farmaco finto, è l’insieme di questi stimoli.
La cura non è solo un atto clinico, è anche un dispositivo simbolico. E come tale può generare effetti placebo o nocebo, a seconda della qualità dell’esperienza che accompagna la terapia.
Il setting di cura – l’ambiente fisico, ma anche quello relazionale– non è neutrale. In oncologia, questo è particolarmente evidente. Per alcuni pazienti, l’ospedale non è solo un luogo di cura, ma un potente stimolo anticipatorio di potenziali sintomi. Succede spesso che i pazienti comincino a sentirsi male già solo varcando la soglia di ingresso del day hospital, o quando sentono determinati odori o suoni. I corpi reagiscono prima ancora dell’infusione, attivati da una memoria fisica ed emotiva stratificata, come mostrano gli studi sull’anticipatory nausea and vomiting (ANV).
Come rispondere a questa inefficacia simbolica che rischia di peggiorare significativamente la qualità della vita delle persone in terapia?
Una risposta interessante viene da uno studio sull’impatto della realtà virtuale immersiva (iVR), realizzato da un team multidisciplinare della Struttura Complessa di Oncologia Medica della Asl Gallura, che ha sperimentato questa innovazione tecnologica all’interno dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e ha ricevuto il primo premio dell’AIOM per la ricerca nel 2024.
Pubblicato su Seminars in Oncology Nursing, lo studio controllato randomizzato a tre bracci ha testato l’efficacia e la sicurezza della iVR per il contrasto dell’ansia, della fatigue e del dolore in 74 pazienti oncologici sottoposti a terapia antiblastica infusiva.
I partecipanti sono stati assegnati a tre gruppi distinti: con iVR, con medicina narrativa e con cure standard. Le misurazioni di impatto sono state realizzate con scale validate prima e dopo il trattamento, in un’unica sessione. Nel gruppo della realtà virtuale sono state verificate anche la cybersickeness e la soddisfazione generale dei partecipanti.
I risultati hanno mostrato che l’ansia è diminuita in modo significativo nel gruppo iVR e in misura minore anche nel gruppo della medicina narrativa, mentre è rimasta invariata nel gruppo di controllo. La fatigue è migliorata significativamente nel gruppo VR, in particolare nelle dimensioni sensoriale/emozionale e cognitiva, mentre è peggiorata nel gruppo standard, mentre è rimasta invariata nel gruppo della medicina narrativa. Il dolore, invece, non ha mostrato variazioni significative, ma i livelli alla baseline erano molto bassi e non c’era quindi margine per una variazione clinicamente rilevante.
L’esperienza in realtà virtuale ha utilizzato un visore immersivo con video a 360° e appositi controller manuali (joystick), che permettevano ai partecipanti di navigare all’interno degli scenari virtuali in modo semplice e personalizzato. I contenuti comprendevano 310 video con una definizione da 4K a 8K suddivisi in 9 categorie di ambientazioni naturali: Africa, colline, fiumi-laghi-cascate, isole, deserti, spiagge, montagne, mare e fondali sottomarini. I possibili sintomi di cybersickness (come nausea, mal di testa, disorientamento o disturbi visivi) sono stati monitorati con un questionario validato, mostrando una non rilevanza della sintomatologia, inoltre i pazienti hanno espresso un alto grado di soddisfazione.
A completare il quadro, lo studio è stato affiancato da una ricerca qualitativa, che ha raccolto le parole dei pazienti subito dopo l’esperienza con la iVR. I temi emersi non parlano solo di “distrazione” o “passatempo”: molti hanno dichiarato di sentirsi “più sereni”, di “non pensare più alla malattia”, di percepire il tempo che “scorre più in fretta”.
Gli autori dello studio sottolineano un limite importante: l’analisi di una sola sessione. I risultati sono promettenti, ma sarà necessario valutare l’efficacia di più sessioni nel tempo, per capire se l’effetto è duraturo e quale valore aggiunto può avere nei diversi cicli di trattamento.
Lo studio per la prima volta ha anche confrontato i risultati del gruppo della iVR con un gruppo coinvolto in un’attività di scrittura, secondo le metodologie della medicina narrativa. La scelta di questo confronto dovrebbe essere approfondita, perché la narrazione agisce con modalità che non allontanano dalla malattia, ma ne migliorano la consapevolezza e la strategia di coping, in particolare nel contesto della relazione con il team curante. Nonostante sia emerso un risultato positivo nella riduzione dell’ansia, probabilmente questo tipo di intervento ottiene maggiori benefici non nel contesto specifico della sessione di chemioterapia, ma in un monitoraggio continuativo nel tempo che consente una maggiore personalizzazione bio-psico-sociale del percorso terapeutico, come emerge in altri studi.
Potrebbe essere interessante confrontare gli impatti della iVR con l’esposizione a musica, video, film che non siano scelti casualmente da ognuno, come spesso avviene, ma proposti come un programma condiviso dal team curante, per verificare il potenziale di impatto di questo tipo di distrazioni, che stimolano l’immaginazione in una modalità meno immersiva e proattiva.
In sintesi, lo studio mostra che l’iVR non è solo una distrazione tecnologica. Abilita una forma diversa di stare nello spazio della cura, in cui lo scenario ospedaliero – fatto di attese, odori e memorie potenzialmente nocebo – viene trasfigurato in un altrove pacificante, che è uguale, ma al tempo stesso diverso, per ogni persona, che contribuisce attivamente a immaginarlo, producendo la propria efficacia simbolica dell’esperienza.
Il prossimo obiettivo del team di Olbia è coinvolgere i pazienti in immunoterapia per esplorare la correlazione con gli outcomes di risposta al trattamento e valutare la capacità della iVR di potenziare la risposta immunitaria, nelle fasi iniziali del trattamento. Un’altra sfida molto interessante che potrebbe dimostrare ulteriormente l’importanza dell’efficacia simbolica nell’efficacia terapeutica e portare allo sviluppo di nuove terapie digitali integrative.